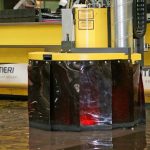Italiani "unfit" per la guerra?

da Il Foglio del 18 febbraio
Le “gaffee” dei ministri Gentiloni e Pinotti sul supposto e poi smentito intervento militare in Libia hanno riacceso i riflettori sulle reali capacità dell’Italia di combattere una guerra. Una “vera” guerra, di quelle non mascherabili da “missioni di pace”.
Quando Renzi ha dichiarato che “non è il momento per un intervento militare”, smentendo così le affermazioni bellicose di Paolo Gentiloni (“l’Italia è pronta a combattere”) e di Roberta Pinotti che aveva ipotizzato l’invio in Libia di 5 mila militari, da più parti anche presso i nostri partner e alleati, hanno ripreso vigore osservazioni e battute umoristiche sull’incapacità dell’Italia di combattere.
 Valutazioni probabilmente accettabili se parliamo della consolidata difficoltà della nostra classe politica, indipendentemente dal colore dei governi, di concepire le forze armate come uno strumento che deve mantenere un elevato tasso di efficienza operativa per tutelare gli interessi e la sicurezza nazionali.
Valutazioni probabilmente accettabili se parliamo della consolidata difficoltà della nostra classe politica, indipendentemente dal colore dei governi, di concepire le forze armate come uno strumento che deve mantenere un elevato tasso di efficienza operativa per tutelare gli interessi e la sicurezza nazionali.
Sul campo però i militari italiani hanno sempre combattuto con determinazione e successo in tante battaglie che nulla avevano a che fare con lo stereotipo della “missione di pace” e per questo sono state tenute spesso nascoste all’opinione pubblica.
Secondo stime non ufficiali nel corso di centinaia di scontri in Somalia nostri militari hanno ucciso non meno di 4 mila miliziani nel 1993/4. Almeno altrettanti i talebani uccisi in battaglia in Afghanistan dal nostro contingente.
 Nel 2004 le nostre truppe in Iraq hanno ucciso centinaia di miliziani nel corso di tre battaglie per i ponti di Nassiryah che probabilmente i guerriglieri sciiti non avrebbero mai cominciato se al nostro contingente fossero stati assegnati subito i carri armati Ariete e gli elicotteri da attacco Mangusta.
Nel 2004 le nostre truppe in Iraq hanno ucciso centinaia di miliziani nel corso di tre battaglie per i ponti di Nassiryah che probabilmente i guerriglieri sciiti non avrebbero mai cominciato se al nostro contingente fossero stati assegnati subito i carri armati Ariete e gli elicotteri da attacco Mangusta.
Armi che, inviate d’urgenza in Iraq, hanno poi scoraggiato ogni altro tentativo degli insorti di prendere il controllo della città.
La politica continua a vedere i militari come uno strumento utile, anche in termini mediatici, a compensare le carenze di altri enti e corpi dello Stato (spalano la neve, pattugliano le strade, rimuovono persino i rifiuti) ma nelle missioni all’estero sono considerati non un supporto alla politica estera ma il sostituto di una politica estera inesistente o inadeguata.
 L’attuale governo non fa eccezione, basti pensare che Renzi non si è mai recato in visita a nessun contingente schierato oltremare.
L’attuale governo non fa eccezione, basti pensare che Renzi non si è mai recato in visita a nessun contingente schierato oltremare.
Anni di missioni spesso sanguinose in Iraq, Libano, Balcani e Afghanistan non ci hanno garantito nessuna penetrazione o sfera d’influenza politica, economica o strategica in quelle regioni.
Le missioni vengono concepite dalla politica italiana come il necessario obolo da pagare agli alleati, di solito agli Stati Uniti, più recentemente e in misura minore all’Unione Europea.
L’anno scorso il Consiglio Supremo di Difesa esortò a mantenere, nonostante i tagli al bilancio, la capacità di partecipare alle operazioni “richieste dalla comunità internazionale”, non quelle imposte dagli interessi nazionali.
 Per questo le forze armate italiane sono caratterizzate dall’imbarazzante paradosso di poter sopravvivere in termini di efficienza solo in presenza di missioni oltremare che garantiscono con i fondi ad hoc (1.,6 miliardi nel 2011, meno di un miliardo nel 2014 e 542 milioni per i primi 9 mesi di quest’anno) la possibilità di addestrare i reparti e mantenere operativi i mezzi necessari anche per combattere.
Per questo le forze armate italiane sono caratterizzate dall’imbarazzante paradosso di poter sopravvivere in termini di efficienza solo in presenza di missioni oltremare che garantiscono con i fondi ad hoc (1.,6 miliardi nel 2011, meno di un miliardo nel 2014 e 542 milioni per i primi 9 mesi di quest’anno) la possibilità di addestrare i reparti e mantenere operativi i mezzi necessari anche per combattere.
Da sempre sotto-finanziato, l’apparato militare italiano ha subito negli ultimi 15 anni tagli ai bilanci pari al 23 per cento in termini reali. Quest’anno quasi il 70,7 per cento dei 13,8 miliardi assegnati alle forze armate alla voce “funzione difesa” sono assorbiti dagli stipendi, il 20,7 viene stanziato per acquisire nuovi equipaggiamenti (voce rinforzata da altri 2 miliardi circa forniti dal Ministero dello sviluppo economico) mentre appena l’8,5% (conto la media del 25% di gran parte dei nostri alleati) è assegnato all’esercizio, voce che copre addestramento, carburante e manutenzione di mezzi e infrastrutture.
 Una tendenza consolidata da molti anni che ha portato ormai alla paralisi l’apparato militare. Il Ministero della Difesa non rivela dati ufficiali ma gira voce che meno del 30 per cento dei velivoli sia operativo a causa di carenze di ricambi e carburante, percentuale che scende al 15% per gli elicotteri dell’Esercito.
Una tendenza consolidata da molti anni che ha portato ormai alla paralisi l’apparato militare. Il Ministero della Difesa non rivela dati ufficiali ma gira voce che meno del 30 per cento dei velivoli sia operativo a causa di carenze di ricambi e carburante, percentuale che scende al 15% per gli elicotteri dell’Esercito.
I piloti volano sempre di meno e interi reggimenti non hanno i fondi per l’addestramento al combattimento.
Negli ultimi anni preparazione adeguata e mezzi efficienti sono stati garantiti solo ai reparti destinati a operare all’estero grazie ai fiondi per le missioni che con il ritiro dall’Afghanistan sono in vertiginoso calo, come il numero di reparti in grado di combattere.
L’Italia sarebbe oggi in grado di schierare in Libia i 5 mila militari indicati dal ministro Pinotti mobilitando le forze di pronto impiego (parà della Folgore, fucilieri di Marina, forze speciali e qualche unità specialistica) ma dopo sei mesi avremmo difficoltà a trovare reparti altrettanto “combat ready” con cui avvicendarli. Rovesciando la celebre frase di Georges Clemenceau verrebbe da dire che in Italia la “guerra è una cosa troppo seria per lasciarla fare ai politici”.

Gianandrea GaianiVedi tutti gli articoli
Giornalista bolognese, laureato in Storia Contemporanea, dal 1988 si occupa di analisi storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra. Dal 1991 al 2014 ha seguito sul campo i conflitti nei Balcani, Somalia, Iraq, Afghanistan, Sahara Occidentale, Mozambico e Sahel. Dal febbraio 2000 dirige Analisi Difesa. Ha collaborato o collabora con quotidiani e settimanali, università e istituti di formazione militari ed è opinionista per reti TV e radiofoniche. Ha scritto diversi libri tra cui "Iraq Afghanistan, guerre di pace italiane", “Immigrazione, la grande farsa umanitaria” e "L'ultima guerra contro l’Europa". Presso il Ministero dell’Interno ha ricoperto dal 2018 l’incarico di Consigliere per le politiche di sicurezza di due ministri e un sottosegretario.