Niccolò Machiavelli stratega: l’attualità di un pensiero immortale

Anticipò tutto Niccolò Machiavelli (1469-1527), geniale nel delineare i canoni dell’idea di ‘Stato-nazione’, partendo da una critica serrata alla corruzione pubblica e morale, alla fiacchezza delle virtù militari e al mercenariato militare. Il Grande fiorentino propugnava già la crucialità di eserciti ‘nazionali’, agili e versatili, sorretti da una strategia sinergica, in cui fossero centrali il fattore umano, la coesione di corpo, l’addestramento accurato e gli elementi spirituali.
Sebbene non fosse un graduato, né avesse frequentato accademie o corsi di Stato Maggiore, Machiavelli forgiò le sue conoscenze politico-strategiche sui libri di storia e le applicò alle vicende militari a lui contemporanee. Nelle varie legazioni, osservò le disposizioni dei potenti, il carattere dei governi e dei popoli. Ritraendo le cose di Francia, notò che l’accentramento dei poteri era al tempo stesso un moltiplicatore di potenza e un riduttore delle libertà individuali. Ma lo preferiva al regime tedesco.
La Germania di Massimiliano I gli sembrava meno funzionale. La Dieta imperiale era un organismo imperfetto. Nessuna regola stabiliva con precisione dove tenere le riunioni e con quale frequenza, chi potesse convocarle e chi dovesse presenziarvi, quali fossero le procedure interne e i poteri dell’assemblea[i]. Prima di decidere, l’Imperatore era costretto a un iter lunghissimo di fastidiose formalità, a scapito della rapidità e dell’efficacia di comando. Un principe che avesse cercato l’amicizia tedesca ne avrebbe tratto per Machiavelli magis nomen quam praesidium, più fama che aiuto concreto[ii].
È il dilemma attuale delle alleanze, di una NATO che integra perfino il Montenegro e, se vogliamo, dell’Europa della difesa in fieri. Quali i reali benefici per l’Italia, che si muove un po’ in ordine sparso anche sulle questioni cruciali delle sinergie industriali? Germania e Francia stanno stringendo i ranghi, a partire dal nuovo patto per il Sahel. Hanno lanciato un aereo da combattimento comune per il 2035-2040 e un progetto di MBT, entrambi ITAR free, insieme a un’unità per il trasporto tattico.
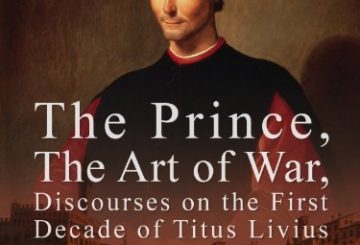
Programmano una miriade di attività congiunte, dai droni ai satelliti. Ma hanno concezioni antitetiche sull’uso della forza militare, a partire dalla catena di comando, presidenziale in Francia e parlamentare in Germania. Parigi ha un fortissimo afflato militar-interventista, Berlino propende invece per la diplomazia e gli aiuti allo sviluppo. Vi destina 24 miliardi di euro l’anno, contro i 9 della Francia (0,7% del Pil contro lo 0,38%). Come i due Grandi possano rilanciare un’Europa della difesa omogenea e fluida non è affatto evidente. Il vero problema dell’integrazione europea è la scelta fra la sovranità nazionale e la maggiore potenza nello stare insieme.
Ma bisogna avere il coraggio di unificare dottrine e concetti operativi e di valicare alcuni tabù ancestrali, condividendo i rischi anche in operazioni in cui gli interessi vitali del proprio cortile di casa non siano in gioco. Proprio il contrario di quanto previsto dalle neo-cooperazioni strutturate permanenti, volutamente annacquate dalla Germania. Per ora il respiro è stato corto. Come lo è ancora quello del quartier generale europeo, più una Direzione che altro, tant’è che l’operazione Atalanta continua ad essere pilotata da Northwood e non da Bruxelles, sebbene un modus vivendi sia stato trovato per Rota. Francia e Spagna hanno fatto fronte comune spiazzando l’Italia, che ambiva al comando di Atalanta.
Non c’è nell’aria nessun miracolo dei pani e dei pesci, tanto è caleidoscopico e vulnerabile lo scenario europeo, scosso da secessionismi latenti e manifesti (http://www.analisidifesa.it/2017/10/le-potenziali-conseguenze-strategiche-dellindipendenza-catalana/). Ricorda da lontano l’Italia di Machiavelli. Chi voglia comprendere i mali di allora potrà trovarne un’epitome nella struttura del sistema viario. L’orografia della penisola aveva favorito la parcellizzazione più che l’accentramento.
L’Appennino si ergeva come spartiacque insormontabile. Ogni capitale di stato regionale catalizzava il suo contado con infrastrutture ganglionari, ottime nel servire il centro, pessime in periferia[iii]. La via Emilia fungeva da arteria principale fra Roma, Rimini, Bologna e Milano. Costruita dai romani, aveva un buon transito di merci e persone. Ma le diramazioni secondarie non erano che sentieri ghiaiosi e ciottolosi, intervallati da tratti in legno e fascine di sterpi. Valicando l’Appennino, seguivano il corso di fiumi e torrenti e l’alea stagionale.
Quando fu abbozzato un ordito ferroviario, i 1.400 km di metà ’800 rappresentavano la sommatoria di cinque isole disgiunte e occorse parecchio tempo prima di riannodarle. Che dire della struttura politica. L’erosione dell’autorità imperiale della Chiesa aveva favorito l’insorgere delle lotte comunali. Principati e signorie, economicamente floridi, usavano assoldare milizie mercenarie e capitani di ventura[iv], chiamare in soccorso eserciti d’oltralpe e permettere loro di soggiogare la penisola.
Era il frutto della realtà politica dell’Italia di fine ’400, magma informe di parti, fazioni e sottoclan. A Milano imperavano gli Sforza, i Trivulzio e i Visconti; a Genova gli Adorno, i Doria e i Fregasi; a Perugia i Baglioni e i Bentivoglio; a Pistoia i Cancellieri e i Panciatichi; a Roma i Colonna e gli Orsini; a Firenze i Medici e così via. Vi era poi il legato di potentati decaduti ma ancora in vita, dagli angioini agli aragonesi, dai guelfi ai ghibellini, dai bianchi ai neri, dai palleschi ai piagnoni.
Elementi interni a ciascuna parte non esitavano a stringere alleanze tattiche con gli avversari storici, dipingendo un quadro di faziosità, partigianerie e affiliazioni, non molto diverso dai rigurgiti contemporanei di malcostume e corruzione[v]. Sebbene perdesse posizioni di mercato, l’Italia centro-settentrionale imperava ancora. A metà Cinquecento, esportava il quintuplo dell’Inghilterra e surclassava sia i francesi (-20%), sia i fiamminghi (-30/40%)[vi]. Fra il Tre e il Cinquecento, la Firenze di Machiavelli aveva un ruolo da protagonista non solo in Italia, ma anche in Europa. Patria di Dante, Boccaccio, Petrarca, Cimabue e Giotto, superava per reddito l’Inghilterra elisabettiana di metà secolo (XVI). Primeggiava in campo bancario e finanziario. Contava un’ottantina di istituti di credito, all’avanguardia negli strumenti finanziari.
Polizze e lettere di credito, buoni del tesoro e sistema della doppia contabilità nacquero nella piazza fiorentina. Una rete di partecipazioni incrociate legava le banche all’industria, come nel capitalismo odierno. A campare coi fiorini era mezza Europa. Edoardo III, re d’Inghilterra per mezzo secolo (1327-77), ne aveva in prestito un milione e mezzo, cifra equivalente ai nostri dieci milioni di euro.
Nerbo dell’economia fiorentina era il comparto tessile, con le sue 200 aziende, gli oltre 30mila addetti, i 70-80mila panni l’anno e il giro d’affari da 1 milione e 200mila fiorini. Aveva conquistato i mercati grazie a tessuti innovativi, sottoposti in tintoria a una trentina di processi di lavorazione e all’occhio vigile di maestranze specializzate. Mentalità e modus operandi erano tipici di un’industria matura[vii], partecipata dalle banche e beneficiaria dei loro crediti d’investimento.
Paradossalmente, la Città non godeva di nessun vantaggio naturale. Non aveva materie prime, né una posizione geografica invidiabile. Il contado non era più ricco di tanti altri e l’Arno era navigabile solo sporadicamente. La vita politica era tutt’altro che ordinata, instabile il governo. Le varie magistrature si ostruivano a vicenda, contendendosi un potere irrazionalmente distribuito. Ai tempi di Machiavelli, c’era un Gonfaloniere di giustizia, esecutore delle leggi e delle sentenze giudiziarie; otto Priori formavano una sorta di Ministero ed eleggevano il presidente (gonfaloniere), mentre il Consiglio del Popolo fungeva da assise parlamentare ante litteram.
Il Segretario all’opera
Nel quindicennio 1498-1512, la sicurezza della Signoria fu messa a dura prova. Firenze era in guerra con Pisa, si appoggiava alle armi francesi, parava le minacce tedesche, disarticolava le trame dei signorotti e paventava il bellicismo del pontefice Giulio II. Mai come allora, l’equilibrio politico-finanziario dello stato vacillò. Machiavelli reggeva all’epoca la segreteria dei Dieci e della Seconda Cancelleria. Ebbe in quelle vicende un ruolo da protagonista, spesso incompreso. I funzionari della 2a Cancelleria avevano compiti operativi e di grande responsabilità, sia in campo diplomatico che militare. Godevano di un osservatorio privilegiato.
Il Segretario era in contatto diretto con il Gonfaloniere, con i più alti magistrati della Repubblica, coi generali e gli ambasciatori stranieri. Sul suo tavolo, si accatastavano relazioni segrete, lettere riservate, rapporti e documenti confidenziali. Machiavelli li leggeva e li chiosava acutamente.
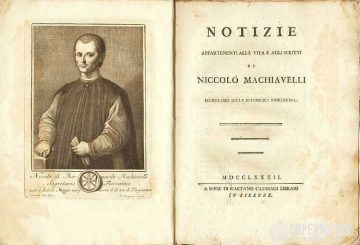
I suoi dispacci per il governo erano spesso crudi e asciutti, ma i contenuti brillavano per acutezza. Formatosi come Segretario dei commissari alla guerra Giovan Battista Ridolfi e Luca degli Albizi, fu mandato in legazione presso gli attori principali dello scenario rinascimentale, dai più potenti signori e condottieri ai papi, dal re di Francia all’imperatore Massimiliano. Dopo una breve parentesi presso Caterina Sforza, contessa di Imola e di Forlì, il 18 giugno 1500 era già in teatro, a seguire le operazioni dell’esercito fiorentino contro Pisa. Fu un’esperienza dolorosa. Firenze allineava fra i suoi anche i reggimenti di Luigi XII, l’ennesimo francese giunto in Italia a prendersi il ducato di Milano e il regno di Napoli, bramoso dei commerci angioini con il Levante. Due anni dopo, Machiavelli era sul fronte romagnolo, in missione con Francesco Soderini[viii], presso il famigerato duca Valentino.
Quando vi tornò fra l’ottobre e il gennaio 1502-’03, ne carpì i metodi. Vide il Duca occupare Pesaro, Cesena, Rimini, Faenza, Urbino e Senigallia; organizzare le Romagne con pugno di ferro e non esitare a sbarazzarsi di un ministro eccessivamente sadico[ix]. Messo in difficoltà da una congiura dei suoi capitani[x], il Valentino li trasse in inganno e li eliminò con spietata freddezza. Pur detestandolo, Machiavelli lo ammirò, pur auspicando un mondo diverso e virtuoso, analizzò i fatti con metodo scientifico, anticipando i canoni della Realpolitik[xi].
I successi di Cesare Borgia gli parvero tuttavia effimeri. Svanito il Duca, affiorava l’uomo, affatto trascurabile. Era un eroe caduco, cui il Segretario dedicò commenti icastici: «aveva acquistato lo stato con la fortuna del padre, e con quella lo perdè»[xii]. Machiavelli malcelava l’astio per i regimi eccessivamente dispotici, accecati dall’assolutismo. Sapeva che quando la ‘grande strategia’ è focalizzata unicamente sulla preservazione del potere politico, la forza armata diventa una sorta di strumento poliziesco, improduttivo nell’efficacia militare. Qualcosa che si è riscontrato in epoca contemporanea nel caso della giunta argentina e del suo strumento militare, duramente sconfitto alle Malvinas.
Le forze armate argentine mostrarono una performance operativa mediocre, fallimentare nell’obiettivo primario di salvaguardare il regime dei Colonnelli. Come un cane che si morde la coda, quella stessa giunta, politicamente indebolita dalla sconfitta, finì col perdere il potere (http://archivio.panorama.it/mondo/Falkland-30-anni-dopo-oggi-Londra-vincerebbe-ancora).
Machiavelli e la sua forma mentis
Torniamo subito a Machiavelli. Il Fiorentino era un cultore di storia antica. I fasti di Roma repubblicana, le conquiste militari e i trionfi civili dei consoli lo ammaliavano. Gli studia humanitatis ne ispiravano l’agenda politica. Machiavelli conosceva il latino e le opere dei classici. Tucidide e Senofonte, Polibio e Sallustio, Tito Livio e Tacito, Frontino e Vegezio, Dionigi di Alicarnasso e Ammiano Marcellino gli insegnavano a ricercare i legami fra politica e storia. Nei suoi scritti, Machiavelli adottò prospettive dirompenti sulla natura e l’esercizio del potere. Estese alla politica i procedimenti analitici e il fervore realistico che informavano le pitture e le sculture degli artisti a lui contemporanei.
Il metodo sperimentale e la bellezza plastica del Brunelleschi, di Donatello, di Leon Battista Alberti, di Leonardo da Vinci, di Michelangelo e di Raffaello sublimarono il Rinascimento italiano[xiii]. Machiavelli cominciò a studiare i fenomeni storico-sociali come atti di natura, regolati da leggi e costanti. Individuarle avrebbe garantito l’optimum all’agire governativo. Negava che la summa potestas potesse discendere da investiture religiose e preferiva concepirla come forza autolegittimantesi o, se preferite, superiorem non recognoscens. Nella sua concezione, lo Stato è fondamento di tutto. Niente gli è impedito, nei limiti dell’ordinamento giuridico e delle possibilità di successo dei mezzi impiegati.
La forma e l’arte di governo dipendono soltanto dalla missione e, per liberare l’Italia dai barbari, lo statista fiorentino sembrava propendere per un principato più che per una repubblica[xiv], pur riconoscendo alla seconda maggior stabilità politica[xv]. Sia l’uno che l’altra erano funzionali al suo ideale, lo ‘Stato (pre)nazionale’, con le sue leggi, le sue armi, il suo sistema politico. Figura centrale del suo Principe è il sovrano, agente dello Stato, o meglio, dello Stato (pre)italiano, istituzione oggettiva, storica e laica[xvi]. Machiavelli non era un sognatore. Sapeva benissimo che senza una rete di istituzioni salde e sinergiche, l’opera illuminata di un monarca avrebbe potuto poco o punto.
Come disse Jean Bodin (1530-1596), chiave di volta dell’architettura statuale è l’agire silenzioso dei funzionari pubblici e della burocrazia esperta di diritto e di finanza. Machiavelli intuì che urgeva un nucleo politico-militare ben saldo. Se non si fosse formato, l’Italia non avrebbe avuto futuro, frammentata e debole in uno scenario europeo in cui la lotta per l’egemonia era in pieno svolgimento.
Le guerre e i mali d’Italia
Due date suonino come un monito diuturno, 1494 e 1527. La prima riecheggia le scorribande italiane di Carlo VIII. Il sovrano francese marciò su Napoli[xvii] con 20.000 uomini e artiglierie copiose. Allineava un gran numero di mercenari. I fanti tedeschi si contavano a migliaia, svizzeri propriamente detti, ma anche oriundi dell’alto bacino renano (Foresta Nera, Alsazia) e del sud germanico (Svevia, Voralberg, Tirolo).
Non mancavano prezzolati olandesi e altri nordeuropei. In quel periodo, la nostra penisola fu teatro di 5 guerre quasi ininterrotte. Eserciti di 20-30.000 unità la attraversarono da un capo all’altro, sperimentando nuove tecniche belliche. Sembrava la Siria di oggi. Nel 1527, si raggiunse il culmine. Roma fu saccheggiata dall’esercito di un altro Carlo, il V, imperatore della dinastia asburgica, re di Spagna e di Napoli. Sia Machiavelli, sia Francesco Guicciardini (1483-1540) guardarono con lucida amarezza al trauma dell’invasione francese[xviii]. Il sovrano d’oltralpe aveva percorso indisturbato l’antica via Francigena, appoggiato dai signori di Milano e Firenze, Ludovico il Moro e Piero de’ Medici.
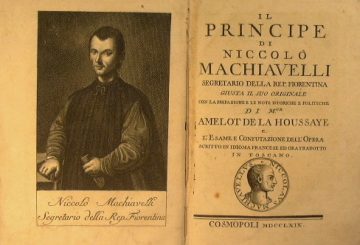
A finanziare l’impresa erano stati capitali toscani, genovesi, milanesi e, in minima parte, lionesi. In cinque mesi di avanzate, i francesi non ingaggiarono nessuna battaglia campale. Quando entrarono a Napoli, nel febbraio 1495, colsero un successo politico più che militare. A Carlo VIII era bastato insinuarsi fra le rivalità dei principi italiani, convinti di poter giocare la carta francese secondo le regole di un equilibrismo ormai sepolto. Il popolo di Firenze ebbe un sussulto d’orgoglio. -Cacciò Piero, ma sarebbe stato inerme contro l’esercito carlista. Fu una dura lezione per l’élite cittadina, che cercò di trarne utili insegnamenti. I dibattiti politici presero a cuore i temi della forza e del potere, centrali negli scritti del Machiavelli.
Al Segretario erano invisi tanto gli stranieri che calpestavano il suolo patrio, quanto gli italiani inconcludenti e la Chiesa corrotta[xix], colpevole di offuscare la religiosità più autentica e di tenere «questa nostra provincia divisa»[xx]. Clero e curia avevano calpestato i valori cristiani e favorito il declino morale della società italiana. Invece la virtù politica di Roma antica era ancorata a un profondo sentimento religioso, che garantiva al bene comune di far premio sull’egoismo individuale, come sempre auspicato da Machiavelli.
La Curia romana a lui coeva tramava al contrario per la disunione. Annaspando nell’impero al tramonto, temeva che un antagonista troppo forte finisse per fagocitarla. Nel suo divide et impera, non esitava a ricorrere allo straniero, noncurante di trasformare la penisola in un campo di battaglia senza orizzonte, alla mercé di francesi, tedeschi e spagnoli. Sarebbe stata emendabile soltanto se fosse riuscita a unificare la penisola. Ma agì in senso opposto e Machiavelli professò il più cinico anticlericalismo. Commise più di un’ingenuità, conobbe il carcere e perfino la tortura[xxi].
Due storie parallele: Dante e Machiavelli
Quando Pier Soderini perse il controllo di Firenze (1512), il suo destino di uomo pubblico fu segnato, insieme a quello di Machiavelli. Entrambi caddero per non più risorgere. Ma come all’esilio di Dante dobbiamo una delle creazioni più alte dell’intelletto umano, così la fine dell’uomo politico Machiavelli coincise con un periodo altrettanto fecondo, in cui l’intellettuale gettò le basi della scienza politica odierna. Nel 1513, fu l’incipit del Principe e dei Discorsi. Il primo fu scritto di getto fra luglio e dicembre, ai secondi occorse molto più tempo, al punto che non oltrepassarono la 1a deca, mentre avrebbero dovuto esser un commento alla storia omnia di Tito Livio. Le due opere sono intimamente legate e mettono a nudo le passioni dello scrittore. Nella prima, Machiavelli gioca la parte del consigliere del tiranno e propugna uno Stato assoluto.
Nella seconda, svela un’insospettabile fede repubblicana, di stampo «imperialista»[xxii]. Di più. Analizza i cicli di crescita e di decadenza delle libere istituzioni, auspicandone la rinascita e ispirandosi all’anakyklosis attribuita da Polibio alla storia delle forme politiche. Le élite colte delle città europee avevano familiarizzato col linguaggio del repubblicanesimo fin dal XII secolo, epoca in cui fu rinvenuta la Politica aristotelica. Abiurando alla genesi divina delle istituzioni, alcune città cinquecentesche si fondavano ormai su un atavico lignaggio di libertà. Sul palazzo comunale di Anversa campeggiava la scritta SPQA, variante del più famoso SPQR. Ai fiorentini bastava appellarsi alle origini etrusche e romane.
Ma l’orizzonte dei più scemava col perimetro delle mura urbane. In Italia, mancava una coscienza unitaria e un sentimento d’appartenenza. «Vano error vi lusinga: poco vedete, et parvi veder molto»[xxiii], aveva scritto significativamente un altro Grande. Il campanilismo dei cronisti e degli storici tardo-medioevali rifletteva il patriottismo ristretto e civico delle repubbliche cittadine, costrette a veleggiare in un clima politico e intellettuale generalmente ostile[xxiv]. Per la maggior parte degli europei, forma naturale di governo era la monarchia, legittimata dal dei gratia.
La concezione ‘machiavellica’ dello Stato e i suoi epigoni
L’afflato ‘patriottico’ valse a Machiavelli l’accostamento a Dante; alcuni guardarono al Principe come all’incarnazione del Veltro. Ma i postulati da cui i due Grandi muovevano erano differenti. Per il Sommo Poeta, la vita politica procedeva da istanze religiose, etiche e morali. In Machiavelli non vi è invece spazio per la trascendenza o, meglio, la religione stessa è instrumentum regni, forza di coesione politico-militare. Cerimonie e riti istituzionalizzati servivano e servono a cementare i legami fra l’individuo e lo Stato: «valevano assai, nel tenere disposti gli soldati antichi […], perché in ogni loro errore si minacciavano non solamente di quelli mali che potessono temere dagli uomini, ma di quegli che da Dio potessono aspettare.
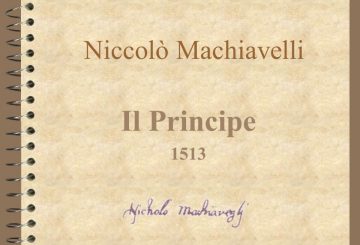
La quale cosa, mescolata con altri modi religiosi, fece molte volte facile a’ capitani antichi ogni impresa, e farebbe sempre dove la religione si temesse e osservasse» [xxv]. Machiavelli è il profeta dell’essere e della verità effettuale, Dante aspira piuttosto al dover essere e spiega i fatti muovendo dalla legge[xxvi]. Scrisse una volta Francis Bacon: «dobbiamo esser grati al Machiavelli e agli scrittori come lui, che ci hanno detto senza peli sulla lingua quello che gli uomini fanno e non quello che dovrebbero fare»[xxvii].
Nessuno più di Richelieu fu miglior epigono di Machiavelli. Fra il 1624 e il 1642, il Cardinale edificò in Francia il primo stato centrale europeo a base territorial-nazionale, grande potenza in fieri.
Per evitare il dramma della guerra civile, Richelieu non esitò a ricorrere alla violenza e all’inganno. Assassinò gli avversari politici, represse con pugno di ferro le rivolte popolari, estorse tasse e imposte, guidato da un’unica certezza, la ragion di stato[xxviii]. In parole povere, un “fine sublime” che giustifica i più infimi mezzi. Alcuni hanno liquidato il pensiero di Machiavelli col noto aforisma, verosimilmente apocrifo, estrapolandolo da un contesto assai più raffinato. «Quanto sia laudabile in uno principe il mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, ciascuno lo intende»[xxix], ma la realtà insegnava a Machiavelli che ciò non sempre è possibile. Il Principe da lui dipinto era uomo e bestia, spirito e corpo, volpe e leone, secondo l’ambivalente doppiezza dell’animo umano. Gli autori classici amavano l’allegoria di Chirone il Centauro, maestro di Achille e di altri principi, in parte uomo e in altra cavallo[xxx].
Un governo può ricorrere alla forza e alla violenza quando i mezzi leciti non bastino a garantire l’ordine e la convivenza civile. Ma sbaglierebbe a dimenticare che i mezzi estremi e ripugnanti si ritorcono spesso contro chi li adoperi. Non solo sono controproducenti, ma anche ‘impolitici’, perché rischiano di dissolvere i legami comunitari[xxxi]. «Coloro che stanno semplicemente in sul lione, non se ne intendono»[xxxii]. Primo dovere dello Stato è trattare i sudditi come cittadini, non come soggetti. Castelli e fortezze sono inutili senza il sostegno popolare, vera garanzia di sicurezza[xxxiii]. ‘Nazione’ e popolo coincidono.
«Un popolo è più prudente, più stabile, e di miglior giudizio che un principe. E non senza cagione si assomiglia la voce d’un popolo a quella di Dio; perché si vede una opinione universale fare effetti meravigliosi ne’ pronostici suoi»[xxxiv]. Spetta al principe inculcare il sentimento di appartenenza nazionale, assicurando allo Stato autarchia difensiva. Scagliandosi contro le milizie mercenarie, Machiavelli indicava nei fattori morali il nerbo della lotta, ed elevava la religione della ‘patria’ a forza morale, politica e militare. Sacrificava l’individuo allo Stato ma, al tempo stesso, ne eleggeva il popolo a difensore supremo: «se si considera il fine dei nobili e degl’ignobili, si vedrà in quelli desiderio grande di dominare ed in questi solo desiderio di non essere dominati, e per conseguente maggior volontà di vivere liberi, potendo meno sperare d’usurparla che non possono i grandi; talché essendo i popolari preposti a guardia d’una libertà, è ragionevole ne abbiano più cura, e non la potendo occupare loro, non permettano che altri l’occupi»[xxxv]. Fondamento del suo Stato è la legge.
Tanto il potere repubblicano, quanto il principesco sono de-limitati dall’ordinamento giuridico. Un principe legibus solutus «è pazzo»; un popolo cui tutto sia concesso non «è savio»[xxxvi]. Il concetto era già caro ad Aristotele (384-322 a.C.) e fu ripreso, ancor prima di Machiavelli, da Nicola Cusano (1401-1464). Ove non imperi la legge, non può esservi una vera politìa, un regime politico democratico. Al Fiorentino spetta il merito di aver ribadito la centralità dell’etica pubblica e del nómos nell’architettura dello Stato-comunità: «come gli buoni costumi per mantenersi hanno bisogno delle leggi, così le leggi per osservarsi hanno bisogno de’ buoni costumi»[xxxvii]. Niente è peggio che tenere «un animo in piazza e un altro in palazzo»[xxxviii].
Machiavelli invitava soprattutto i potenti al rispetto della legge, sottolineando l’importanza della coerenza nell’agire politico: «io non credo che sia cosa di più cattivo esempio in una repubblica, che fare una legge e non la osservare, e tanto più, quando la non è osservata da chi l’ha fatta»[xxxix]. Parole sante, che suonano di un’attualità stringente.
La critica al mercenariato militare
Nella Relazione sull’istituzione della nuova milizia (1506), Machiavelli aveva già enunciato il principio morale delle milizie nazionali e lo ribadì nel Principe, nei Discorsi e nell’Arte della Guerra: “et vi advedrete […] che differentia è havere de vostri cittadini soldati per electione et non per corruptione”. Era profondamente convinto che le arti della politica e della guerra fossero intimamente legate e che la perfezione della seconda derivasse dalla compiutezza della prima. Suggeriva un ritorno al passato romano, alla simbiosi tra buone leggi e buone armi[xl]. Pochi anni prima (1430), Matteo Palmieri aveva enfatizzato la disciplina e lo spirito di sacrificio degli eserciti romani[xli]. Sapeva, come Machiavelli, che una forza militare non può prescindere dall’amor patrio e dagli alti valori dell’etica civile, dignità, rispetto, onore e coraggio.

Per entrambi, l’apogeo greco-romano era il frutto di un indirizzo unitario in politica e di uno scopo chiaro in guerra, oltre che di ottimi cittadini-soldato, legionari per aspirazione e dovere, non per mestiere. La storia racconta tuttavia che, senza una nuova base di reclutamento, Roma non avrebbe potuto espandersi. Nel IV secolo a.C., i legionari, piccoli proprietari terrieri, erano divenuti il serbatoio di un esercito di mestiere, profondamente diverso dal modello greco.
Spina dorsale erano i centurioni, ufficiali di grande esperienza provenienti dalle fila dei soldati semplici. Depositari di sagacia tattica e dei codici di disciplina, essi rappresentavano l’anello di congiunzione fra una generazione e l’altra. Grazie a loro, le armi romane sconfissero uno dopo l’altro «un centinaio di popoli nemici, durante cinque secoli di guerre pressoché ininterrotte»[xlii]. Machiavelli era consapevole che al crollo dell’Impero romano d’Occidente aveva contribuito tutta una serie di cause, dal trasferimento della sede imperiale a Costantinopoli alla corruzione diffusa, dall’espansionismo islamico alla rottura dell’unità mediterranea, per non dire dello strumento difensivo, progressivamente snaturato[xliii].
Nel 370 d.C., metà circa dell’esercito era composta a Ovest da soldati franchi, alemanni e vandali, a Est da goti e sarmati. I barbari abbondavano anche fra gli ufficiali superiori, nella cavalleria e nelle truppe scelte imperiali. La difesa di Roma dipendeva dagli stranieri. Il dissolvimento fu drammatico, rivelatore di errori di valutazione e prospettiva. Machiavelli riteneva le milizie mercenarie e straniere pericolose in pace e inutili in guerra, gagliarde fra gli amici e vili fra i nemici[xliv]. Esse non esitavano a servire il miglior offerente e a tradire non appena il nemico offrisse loro mercedi più vantaggiose. Avevano un seguito di carri pesanti.
Nei periodi di ‘disoccupazione’, «sendo privi degli stipendi e del vivere […]», cedevano «sanza alcuna piatà»[xlv] all’uzzolo di bottino e ne riempivano i carriaggi. Ricattavano spesso le città, estorcendo denaro in cambio di un’immunità effimera dai saccheggi. La Pisa e la Firenze trecentesche sborsarono a fra’ Moriale[xlvi] migliaia di fiorini (16 e 20 mila), per un solo biennio irenico. Machiavelli andò giù pesante. Nella battaglia di Zagonara, non morirono a suo dire che Lodovico degli Obizzi e altri due, «i quali cascati da cavallo, affogarono nel fango»[xlvii]. In quella di Anghiari, vi fu un solo caduto, non certo per coraggio o «altro virtuoso colpo»[xlviii], ma perché disarcionato dalla bestia.
Era un disprezzo eccessivo, ma fondato. L’Italia era da troppo tempo teatro di scontri fra potenze straniere. Le prime compagnie di ventura erano giunte d’oltralpe nel ’300, al seguito di sovrani germanici come Arrigo VII, Ludovico il Bavaro e Giovanni di Boemia. Sebbene ne fossero spuntate un po’ ovunque, avevano allignato soprattutto in Italia e Germania, prive di una forte autorità centrale.
Degli svizzeri e dei lanzichenecchi
Da 400 anni, i mercenari elvetici erano i più ambiti. Seppero ritagliarsi spazi imprescindibili in tutti i grandi eserciti dell’età moderna. In Francia, rimpiazzarono gli arcieri della milizia mobile. In Germania, ispirarono i famigerati Landsknechte di Georg von Frundsberg, autore del sacco di Roma (1527). La Svizzera era per Machiavelli un modello perfetto di autodifesa. Compiuti i 16 anni, tutti gli uomini erano chiamati a un addestramento continuo, conciliabile con le attività economiche, prevalentemente pastorali. A tenere uniti i cantoni, autonomi l’uno dall’altro, era la volontà di preservare l’indipendenza e il diritto all’autogoverno[xlix].
Gli Elvezi d’origine celtica erano il ceppo prevalente. Bellicosi e indomiti, erano talmente coraggiosi, disciplinati e resistenti, da esser rinomati perfino all’epoca di Giulio Cesare, che se ne servì in battaglia. Nerbo dell’organizzazione militare svizzera era la falange. Armata di picche, sprigionava una forza d’urto capace di contrastare la cavalleria nemica e di attaccarla. Resse splendidamente anche di fronte a Carlo il Temerario (1477), duca di Borgogna, da tutti temuto per la forza della truppa, moderna e professionale.
Quando si trattava di difendere la madrepatria, gli svizzeri erano insuperabili. Nel 1499, fecero strame dei lanzichenecchi ‘svevi’, che avevano osato avventurarsi nelle loro valli, confidando incautamente nella superiorità numerica[l]. Come Machiavelli, tanta parte della filosofia greco-romana condannava la pratica del mercenariato negli eserciti. Platone riconosceva ai capitani di ventura grande coraggio personale, ma ne deplorava gli eccessi di efferatezza e di ingiustizia[li]. Aristotele li biasimava, ritenendoli uno strumento in mano ai tiranni per opprimere i sottomessi. Per entrambi, mancavano di coinvolgimento e di affidabilità, ad onta della destrezza nell’uso delle armi[lii].

Nell’orazione Sulla pace, il grande oratore Isocrate esorta i suoi concittadini ateniesi a restaurare la gloriosa tradizione delle milizie cittadine e a ripudiare l’uso di truppe mercenarie: «poco manca che dichiariamo guerra al genere umano, ma poi […] la facciamo combattere da apolidi, disertori, gentaglia che ha commesso malefatte d’ogni sorta e che, se qualcuno la pagherà meglio, sarà pronta a seguirlo e a rivolgersi contro di noi […]. Siamo ben peggiori dei nostri antenati […]: essi infatti […] affrontavano i pericoli della guerra con le loro genti»[liii].
Le frontiere e il popolo di uno ‘Stato’ sono inviolabili per Machiavelli, estimatore di Vegezio (IV-V sec. a.C.). Il suo De re militari è un panegirico degli eserciti della repubblica romana. I legionari vi sono preferiti agli ausiliari, i civili armati ai mercenari[liv]. Nella Firenze del Trecento, lo stesso Petrarca si scagliò contro i condottieri. Poco più che ladri e assassini, gli parevano mossi dal solo desiderio di bottino, preoccupati più dell’incolumità personale che di sconfiggere il nemico. Non diversamente la pensava Coluccio Salutati, in quegli anni cancelliere di Firenze.
Arcinemico dei condottieri, reputava i mercenari degli emarginati, sempre intenti a tramare contro l’ordine e la pace. Ai cittadini, Salutati chiedeva dedizione agli affari militari della Res publica, volizione che in Machiavelli diventa Virtù[lv] per antonomasia, energia dell’uomo e forza creatrice, capacità di incidere sulla realtà, nel bene e nel male. È la volontà che diviene valore in sé, secondo l’insegnamento sempiterno di Dante. Nell’Inferno, vi è un vestibolo ad hoc per gli ignavi, uomini che non seppero votarsi né al bene, né al male.
Guerrieri e guerre ai tempi di Machiavelli
Molti condottieri rinascimentali conoscevano non meno di Machiavelli le opere degli scrittori militari classici. Giulio Cesare, Polibio ed Eliano allevarono intere generazioni di guerrieri. Maurizio di Nassau (1567-1625), generale fra i più insigni del suo tempo, soleva leggere i commentari di Lipsio a Polibio. Ispirandosi all’organizzazione tattica romana, fece del reggimento l’unità base della fanteria. Per addestramento e ordine di battaglia, le sue truppe divennero il paradigma di riferimento di molti eserciti contemporanei. Quando scavava trincee, fortificava campi o schierava le truppe in file separate, anziché in quadrati, aveva in mente gli insegnamenti delle guerre galliche. I comandanti romani si erano accorti che le falangi dalle file serrate erano poco efficaci contro i nemici d’oltralpe, usi a combattere in ordine sparso e dinamico.
Concessero ai manipoli maggior spazio di manovra. La lancia cedette al pilum, un giavellotto che il soldato scagliava prima di ingaggiare il nemico con la spada. Paradossalmente, mentre la penisola era in balia dei nuovi barbari, gli Italiani continuavano ad esser un modello anche nelle cose militari[lvi]. Diversamente dai legionari romani, i veliti di Machiavelli non sarebbero stati soldati di mestiere, né avrebbero potuto avere quell’hybris pugnace che contraddistingue i veri guerrieri. Espressione diretta della società produttiva, erano soprattutto contadini, ma non mancavano «legnaiuoli, fabbri, maniscalchi, scalpellini, ingegneri, bombardieri»[lvii], ausiliari impiegati per gli alloggiamenti. Ai coscritti, si affiancavano i volontari. Machiavelli sapeva del legame ineluttabile fra ordinamenti militari e struttura economico-politica della nazione.
Per salvaguardare le attività della borghesia urbana, reclutò soprattutto nel contado. Stimava grandemente il mondo agricolo. Reputava i contadini rotti ai «disagi, nutriti nelle fatiche, consueti stare al sole, fuggire l’ombra, saper adoperare il ferro, cavare una fossa, portare un peso ed essere sanza astuzia e sanza malizia»[lviii]. I romani ne avevano fatto il bacino per antonomasia delle truppe indigene. Ma a un buon esercito occorrono tanto i soldati, quanto l’efficienza amministrativa e fiscale[lix]. La nascita di Stati nazionali in Francia e in Castiglia rivelò la fragilità dei potentati italiani. Lì si liberavano enormi risorse per muover guerra, qui sempre meno. Stato-nazione significava possibilità di organizzare e mantenere un apparato militare permanente, con mezzi inarrivabili per gli staterelli peninsulari[lx]. Machiavelli ammonì contemporanei e posteri. Qualsiasi potenza «non sua vi nixa»[lxi], non basata sulle proprie forze, è senza futuro.
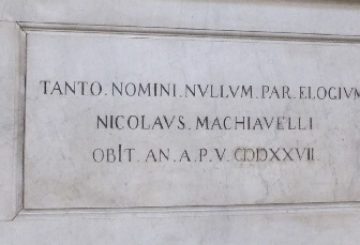
Se l’unità era il rimedio alla crescente supremazia straniera, la vis militare era l’atout per contrastarla. La potenza delle artiglierie campali stava allora mutando l’architettura difensiva. Alle torri tonde unite da mura subentrarono terrapieni bassi e massicci, capaci di reggere l’urto più violento delle bocche da fuoco cinquecentesche. La trace italienne moltiplicò gli assedi di lunga durata, i costi logistico-finanziari e la numerosità delle truppe. Tra il ’500 e il ’600, schierare un soldato divenne 5 volte più caro che in passato[lxii].
Espugnare simili baluardi richiedeva fanti più che cavalieri, potenza di fuoco enorme, tempo e denaro. Machiavelli diffidava però dal considerare la ricchezza materiale vero «nervo della guerra»[lxiii]. Sebbene necessaria, la riteneva insufficiente a plasmare un buon esercito. Con validi soldati, è invece facile «trovar l’oro»[lxiv].
L’imprescindibilità di forze armate nazionali
Facciamo un passo indietro. Nel settembre del 1503, Firenze fallì un nuovo attacco contro Pisa. Aveva assoldato i migliori condottieri italiani e tentato ogni espediente, come la deviazione del corso dell’Arno per assetare il nemico. Confidava nell’aiuto francese, ma i 5mila mercenari svizzeri di Luigi XII si rivelarono inaffidabili e indisciplinati. Capitanati da Hugo de Beaumont, avrebbero dovuto dare un colpo decisivo all’assedio, ma anziché impegnarsi nel pattuito, trovarono più profittevole saccheggiare Bologna, razziare in Romagna e nel contado pisano. Non paghi, si ammutinarono e imprigionarono perfino il commissario fiorentino alla guerra, Luca degli Albizi.
Vivendoci a contatto, Machiavelli rafforzò il biasimo per i mercenari. In quei frangenti, il suo pensiero correva a Cesare Borgia, che aveva sperimentato sia le milizie ausiliarie (francesi), sia le mercenarie. Scontento di entrambe, le sciolse e «volsesi alle proprie […]; né mai fu stimato assai, se non quando ciascuno vidde come lui era intero possessore delle sua arme»[lxv]. La Patria non potrebbe avere uomini migliori di chi è disposto «a morire per lei»[lxvi]. Disse una volta ai tempi nostri il capitano Otto Skorzeny: «quando un uomo è mosso dal puro entusiasmo e dalla convinzione di rischiare la propria vita per una nobile causa, egli possiede gli elementi principali per ottenere il successo»[lxvii]. Immolarsi e amare la polis non è meno alto e assoluto della tensione fideistica verso Dio.
La fondazione di uno Stato è opera di profeti armati, ma si nutre dell’apporto di tutto un popolo. Il principe è guida politica e soprattutto militare [lxviii]. Dotatosi di un esercito nazionale, lo comanda in battaglia, perché non vi è guerriero più saldo di chi sia onorato e guidato dal proprio sovrano[lxix]. È il famoso «comandare, comandare, comandare», tanto basilare nell’opera odierna del colonnello Fuller, uno dei rari autori europei a interessarsi approfonditamente della guerra di secessione americana. Lo scenario era mutato, ma Fuller provò a dimostrare la condizione ottimale di un capo militare che non fugge il pericolo del fronte ed esercita un comando più efficace, come fecero su sponde opposte i generali Grant e Lee. Tornando a Machiavelli, c’è qualcosa che non torna.
I contadini armati del Valentino erano meri guastatori, non combattenti stricto sensu. La truppa era in gran parte mercenaria. Machiavelli, nazionalista fino all’osso, preferì tacerlo[lxx]. Dopo la disfatta, fu spedito oltralpe, segretario dell’ambasciatore Francesco della Casa, con l’obiettivo di protestare per la diserzione delle truppe franco-svizzere. Ne approfittò per conoscere il Paese e la sua lingua. Inviò a Firenze resoconti talmente acuti e icastici, che fu promosso di grado. La macchina statale francese lo affascinava.
L’architettura istituzionale era solida, così come le forze armate, ben inquadrate e guidate da un ceto nobiliare e alto-borghese coinvolto nelle fortune della patria[lxxi]. Capì quanto i francesi disdegnassero la pochezza politico-militare di Firenze e si convinse ancor più che il popolo dovesse esser armato, per la stabilità dello Stato e l’immunità dalle manovre dei Grandi. Tornato in Italia, trascorse il biennio più intenso della sua vita a forgiare la milizia fiorentina. Attraversò in lungo e in largo Mugello e Casentino, a caccia di fanti da arruolare ed equipaggiare. Nel febbraio 1506, sfilò in parata la prima unità. Quattrocento uomini marciarono fra due ali di folla. Vestivano un farsetto e una sorta di chepì, calze bianco-rosse, scarpette e un pettorale in ferro. Alcuni brandivano lance, altri archibugi, armi da fuoco portatili con gittata fino a 50 metri.
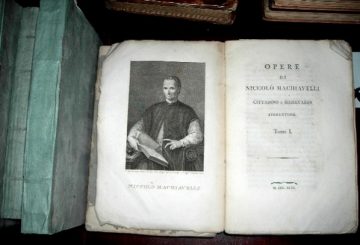
Pochi mesi dopo, Machiavelli ebbe la nomina a cancelliere dei Nove dell’ordinanza e della milizia fiorentina, magistratura da lui stesso voluta, incaricata degli affari militari della Repubblica. Nel sovrintendere all’organizzazione del nuovo esercito, fece fruttare le lezioni apprese dagli svizzeri, dai tedeschi e dalla storia militare greco-romana. Il battaglione di 6.000 unità, tatticamente simile alla legione manipolare romana, fu preferito alla falange di 10mila uomini. Sarebbe stato più agile, sciolto e scaglionabile in profondità.
Avrebbe permesso la successione degli sforzi e il miglior impiego dei singoli[lxxii]. La fanteria primeggiava sulla cavalleria[lxxiii] e le capacità di manovra organica facevano premio su tutto «perché lo esercito animoso non lo fa per essere in quello uomini animosi, ma lo esserci ordini bene ordinati»[lxxiv]. Centrali erano le figure degli ufficiali e dei quadri intermedi, i capodieci o decurioni, soldati di mischia più esperti della media della truppa, come i sergenti e i caporali odierni, pietre miliari della solidità delle fanterie sul terreno[lxxv]. Sebbene le forze degli eserciti si calcolassero ancora in base al numero di cavalli, Machiavelli riteneva che 300 animali fossero sufficienti per una brigata di 6.000 fanti[lxxvi]. Difficile dargli torto.
L’introduzione massiccia delle armi da fuoco portatili aveva reso sempre più obsoleti gli organici di cavalleria. Quando Francesco I si scontrò a Pavia con Carlo V (1525), allineava un esercito più numeroso, 20.000 fanti e 10-12.000 cavalieri, contro altrettanti fanti e 2.000 cavalieri appena. I francesi si illusero di poter sopraffare l’avversario con cariche di cavalleria, ma furono sterminati dai quadrati tedeschi e dal fuoco degli archibugi. Francesco I, che guidava i suoi, fu catturato e deportato a Madrid. La battaglia di Pavia impressionò tanti. Da quel momento in poi, pochissimi eserciti avrebbero ingaggiato battaglie campali decisive. Nel trentennio che seguì, si contarono non più di 4 grandi scontri.
Per vincere, si sarebbe ormai puntato sul logoramento dell’avversario, fino alla bancarotta finanziaria. Qualcosa che fece enunciare a Machiavelli uno dei principi cardine della sua ars bellica: «meglio è vincere il nimico con la fame che col ferro, nella vittoria del quale può molto più la fortuna che non la virtù»[lxxvii]. Sebbene la cavalleria non giocasse più un ruolo centrale, sarebbe servita per «fare scoperte, per scorrere e predare i paesi, per seguitare i nemici quando e’ sono in fuga, e per essere ancora in parte una opposizione ai cavalli degli avversari»[lxxviii].
La concezione spiritualistica della guerra
Alcuni hanno rimproverato a Machiavelli di aver sottovalutato il ruolo delle artiglierie e della tecnologia nella guerra moderna. I cannoni stavano diventando sempre più omogenei, maneggevoli ed efficaci, ma non erano decisivi che nell’impiego a massa. Le fanterie ne beneficiavano poco. Le armi portatili erano talmente imprecise da esser inferiori all’arco e alla balestra. Machiavelli ne ammetteva un uso limitato, pur prediligendo un equipaggiamento più vicino ai canoni degli antichi romani.

Riconosceva ai calibri pesanti validità contro le fortificazioni e i campi trincerati, ma li riteneva poco utili in altri scenari. Era sconcertato dal numero crescente di pezzi al seguito delle truppe. L’artiglieria è «utile in uno esercito quando vi sia mescolata l’antica virtù, ma senza quella contro uno esercito virtuoso è inutilissima»[lxxix]. Un monito sempiterno, rivolto soprattutto a chi, nutrendo una fede cieca nella superiorità tecnologica, tenda a sottovalutare la centralità del fattore umano, delle forze morali, del modello organizzativo e dell’incommensurabile in guerra[lxxx].
L’innovazione organizzativa ha rappresentato spesso la chiave del successo militare, soprattutto in situazioni di parità tecnologica, come dimostrato acutamente da Edward Luttwak, Machiavelli guardava alla pugna non come a un cozzo d’armate, ma come a una lotta fra Uomini, suggello di vis spirituale più che materiale: «che la guerra si ridurrà tutta in su le artiglierie, dico questa opinione essere al tutto falsa […] perché chi vuole fare uno esercito buono, gli conviene […] assuefare gli uomini suoi ad accostarsi al nimico, e venire con lui al menar della spada»[lxxxi], vero rimedio alla tendenza fra le più pericolose in guerra, il desiderio di uccidere senza sacrificarsi. A decidere le battaglie sono sempre stati il coraggio dei soldati, l’abilità dei comandanti e le capacità di resistenza di un popolo, spesso sottovalutate dal potere politico.
La storia militare insegna invece che, anche nei conflitti più cruenti, la resilienza delle opinioni pubbliche ha superato di gran lunga le aspettative. Basti pensare al popolo britannico e russo nella seconda guerra mondiale, o al caso di scuola di Verdun nella Grande Guerra. Machiavelli l’aveva già intuito, enfatizzando il ruolo costitutivo del popolo nella saldezza delle istituzioni. Sapeva inoltre benissimo che la cavalleria bardata di ferro e le pesanti artiglierie del tempo[lxxxii] erano limitate dal terreno e dalle condizioni atmosferiche. Per spirito offensivo e forza morale, non reggevano il confronto con le fanterie.
Non basta, avere soldati qualitativamente eccelsi significava poter compensare un’eventuale inferiorità quantitativa[lxxxiii]. La storia greca e romana abbondava di episodi in cui pochi valorosi, disciplinati e motivati, prevalevano su orde barbariche. Dalle Termopili a Maratona, l’individuo primeggia sulla massa, la qualità sulla quantità, il piccolo, il civilizzato e il conosciuto sull’immenso, il barbaro e l’ignoto. Ricordiamocelo in tempi di frontiere friabili. Gli ordini antichi non forgiavano servi imbelli, ma eleggevano il cittadino a supremo difensore della Res publica. Nella falange greca, tutti gli uomini in grado di impugnare scudo e sarissa difendevano la sopravvivenza fisica della polis e ne incarnavano l’identità spirituale. I piccoli eserciti della democrazia ellenica traducevano la tensione politica e morale in una tattica violentemente aggressiva. Impugnavano armi concepite per il combattimento corpo a corpo. Fronte a loro, le moltitudini persiane potevano oscurare il sole dardeggiando, ma non reggere onorevolmente uno scontro in punta di lancia o di spada[lxxxiv].
Atout e vulnerabilità dell’esercito ‘signorile’
Pur non essendovi limiti d’età al reclutamento dei militi fiorentini, i Nove di Machiavelli preferirono circoscriverlo ai giovani d’età compresa fra i 16 e i 30 anni. Reggenti e sindaci dei comuni avevano l’obbligo di presentare entro il 1° novembre di ogni anno l’elenco degli arruolabili dai 15 anni in su. I soldati godevano di alcuni privilegi, dalla cancellazione delle eventuali pene pecuniarie, alla divisa fornita dalla Signoria, al porto d’armi, un po’ come avviene oggi in Svizzera e in Israele, con ottimi cittadini-soldato liberamente armati. Alla fine la Milizia arrivò a inquadrare 20.000 unità.

Tutti gli effettivi avevano in dotazione una barra di ferro per la difesa; le lance erano appannaggio del 70% degli uomini, gli scoppietti del 10%, balestre, ronche, spade e spiedi dei restanti. Nel complesso era un armamento obsoleto, simile a quello che equipaggiava i quadrati svizzeri nelle guerre borgognone di metà ’400. Ai fanti era richiesto un addestramento continuo, secondo l’uso tedesco che impegnava tutti i giorni festivi, un dì al mese tra maggio e ottobre, e altre tre volte nel resto dell’anno. Quando i battaglioni non venivano radunati, gli uomini dovevano esercitarsi nei comuni di appartenenza.
Le qualità da affinare erano la velocità, la destrezza e la forza[lxxxv]. Ma erano ammesse ampie deroghe all’assiduità di frequenza, il comandante aveva scarso potere coercitivo e la disciplina ne risentiva. Le esercitazioni generali erano numericamente insufficienti a fronteggiare eserciti professionali e ancor meno a condurre offensive, che Machiavelli stimava quale forma suprema di lotta. I romani combatterono quasi sempre «per offendere altrui e non per difendere loro»[lxxxvi], dando vita, nelle battaglie campali, al combattimento più alto e onorevole[lxxxvii]. Un modus operandi non sempre agevole da replicare, che somma alla performance operativa una sapienza strategica di base. L’esempio tedesco del secolo scorso calza a pennello. Passando da una strategia difensiva nel 1935 a una offensiva, la Germania commise diverse leggerezze.

Essendo stata costretta dal trattato di Versailles a ottimizzare le forze armate per una guerra difensiva limitata, si sforzò di adattarsi alla nuova strategia. Ma lo fece unicamente nel campo tattico. La logistica, per lo più ferroviaria e ippotrainata, come l’intelligence militare si rivelarono inadeguate a una guerra offensiva, ereditate in toto dalla Reichswehr, l’esercito della repubblica di Weimar.
Le prodezze tattiche inziali non ne evitarono infatti la disfatta finale, nonostante i successi folgoranti nelle vicinanze immediate del Reich. Se scopo della guerra è annientare il nemico, impiegare la forza con astuzia e veemenza è il metodo consigliato da Machiavelli[lxxxviii]. Nella sua opera risuonano molto in nuce il concetto di superiorità relativa e, fortissimi, l’importanza del fattore sorpresa e dei segnali premonitori in battaglia, con soldati adusi a coglierne il senso al volo. Quasi un’anticipazione del lavoro svolto dall’intelligence e dalle forze speciali odierne.
La mente corre all’azione del generale Kurt Student nella seconda guerra mondiale. Con l’attacco al forte di Eben Emael, il Generale dimostrò che 62 uomini scelti, motivati, ben equipaggiati ed eccezionalmente addestrati potevano sconfiggere una forza dieci volte superiore. Per vincere, è tanto importante conoscere l’avversario quanto confidare nei propri mezzi e avere uomini motivati. Arrivando all’oggi, le operazioni in corso nel Sahel consacrano la primazia dell’iniziativa e dell’audacia. La guerra irregolare è uno dei fenomeni più complessi da addomesticare, tanto più quando la minaccia terroristica islamista è polimorfa, cangiante, mobile e transnazionale.
I (pochi) risultati migliori delle operazioni Serval e Barkhane sono arrivati solo da operazioni contingenti e di opportunità, che hanno imposto all’avversario irregolare un modus operandi altrettanto asimmetrico, almeno nella gestione del fattore tempo, colpendo il nemico al momento meno atteso.
La capacità di dirompenza strategica è spesso determinante, ma presuppone una decisione politica rapida e un’applicazione altrettanto immediata, per garantire la sorpresa, come avvenuto nell’Adrar des Ifoghas contro i santuari di AQMI. Anche i ciadiani, liberatori di Kidal, si sono rivelati preziosi. Hanno mostrato un’efficacia operativa invidiabile, padroneggiando alla perfezione le azioni hit-and-run, mordi e fuggi, mutuate dalla vecchia tattica saheliana del rezzou (razzia), devastante e brutale. Colonne leggere e rapidissime di pick-up, con le sole mitragliatrici da 14,5 mm, hanno rimpiazzato i cammelli d’antan. Sciamano oggi sull’obiettivo e altrettanto repentinamente si dileguano, dopo aver animato un combattimento aspro e pungente, denso nell’avvolgere il nemico in una coltre di fuoco.

Ma torniamo a ieri. Influenzato dal Frontino, Machiavelli suggeriva al comandante di un’operazione di ingegnarsi a sorprendere e dividere le forze nemiche, destabilizzarne gli uomini e dissimulare, «perché non è cosa nella guerra più utile che tacere le cose che si hanno a fare»[lxxxix]. Aveva già compreso che impedire la fuga di informazioni è di importanza vitale, per evitare che notizie sensibili possano fuoriuscire anche accidentalmente e compromettere un’operazione. È uno degli assiomi del concetto di superiorità relativa, principio cardine del modus agendi delle forze speciali o meno, che si ingegnano a sorprendere l’avversario così velocemente da non permettergli di reagire. Machiavelli rafforza e loda il principio: «ancora che usare la fraude in ogni azione sia detestabile, nondimeno nel maneggiar la guerra è cosa laudabile e gloriosa, e parimenti è laudato colui che con fraude supera il nimico, come quello che lo supera con le forze»[xc].
Dividere ed ingannare il nemico è quanto hanno fatto recentemente gli Spetsnaz dell’intelligence militare russo nella battaglia di Aleppo, dando un contributo decisivo alla liberazione del dicembre 2016. Un intero battaglione ha preso parte alle operazioni, strutturato in 30 equipe Alpha di una decina di incursori ciascuno, alcuni dei quali versati nei dialetti arabi siriani. La missione principale è stata quella di frammentare i gruppi ribelli, eliminando il maggior numero di comandanti nemici e ghermendo alcuni punti strategici. Tutto è iniziato con l’infiltrazione ‘clandestina’ nel perimetro dell’Est cittadino, con la creazione di punti di osservazione privilegiati e la selezione accurata di alcuni informatori locali, reclutati e assoldati fra gli abitanti. Quasi simultaneamente sono entrati in gioco gli sniper dei team Alpha, in genere tre per ogni equipe, che hanno eliminato direttamente alcuni responsabili nemici, o ne hanno segnalato le coordinate GPS ai caccia-bombardieri e agli elicotteri.
Gli altri uomini dei team si sono dati alla caccia e alla guida del fuoco aria-terra sulle imboccature dei tunnel nemici, sorta di gruviera sotterraneo che assicurava ai jihadisti massima mobilità da un immobile all’altro. Un mix di missioni che ha messo in grossa difficoltà il nemico, disarticolandone la difensiva. Sebbene le forze speciali fossero inesistenti all’epoca del Machiavelli, i principi della sua opera sono tanto eterni quanto validi ancora oggi. Nella sua milizia fiorentina, i soli professionisti erano i conestabili, ufficiali comandanti le battaglie, unità di 450 uomini circa. A livello inferiore erano le bandiere, con un capitano, un tamburo e un dato numero di capisquadra o caporali. Dall’unione di 2 o più bandiere nasceva la battaglia e da 10 di queste il battaglione, di 4.000 uomini prima, di 8.000 poi. In termini odierni, diremmo compagnie, battaglioni e brigate.
A livello operativo, Machiavelli propugnava tanto l’attacco d’ala, quanto la manovra avvolgente, similmente a quanto fatto da Annibale a Canne[xci]. Ritenendo insulsi gli ordini prestabiliti e immutabili, suggeriva di lasciare al comandante in teatro la massima libertà di azione, così da sfruttare al meglio l’alea del combattimento[xcii]. Da ottimo umanista si elevò qui in massimo stratega.
Mise al centro del suo pensiero la pianificazione creativa, priva di formule semplici e precostituite, perché l’incertezza è un presupposto essenziale della strategia: «sapere nella guerra conoscere l’occasione e pigliarla, giova più di niuna altra cosa»[xciii]. Non per caso i migliori strateghi e polemologi contemporanei come Basil Liddell Hart hanno sempre stabilito un legame indissolubile fra incertezza e successo.
È spesso l’inatteso a offrire le migliori chance di vittoria, purché si abbiano a monte una vision fatta di razionalità ed empirismo, obiettivi chiari e modalità di applicazione fluide, articolate su più livelli d’azione che passino agilmente dalla politica alla grande strategia, e da questa alla strategia stricto sensu, fino alla grande tattica, alla semplice tattica e infine alla tecnica.
Qualcosa che ricorda le matrioske russe, perfettamente intersecate fra loro. Disse una volta Napoleone: «ho concepito molti piani, ma non ho mai avuto la libertà di eseguirne uno solo» (vedi PDF 5, p. 2). Vinse perché fu maestro nel decidere un porto verso cui dirigersi, adattando la rotta a seconda delle circostanze, ricorrendo talvolta a escalation improvvise. Per rimescolare le carte e dare una svolta radicale all’andamento delle cose può essere necessario ribaltare i piani e cambiare postura, ingaggiando in un colpo solo molti più mezzi. Può essere la via al successo militare o a negoziati più fruttuosi.
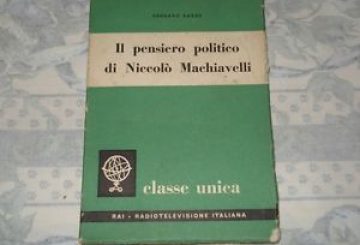
È quanto tentarono il generale De Gaulle nell’Algeria del 1957, con il piano Challe, e Richard Nixon nel Vietnam del 1972. I francesi non ottennero i risultati politici sperati, mentre gli americani poterono se non altro lasciare il teatro con onore.
Negli ultimi anni, l’unico caso di surge parzialmente riuscito è quello americano in Iraq, nel 2007, con il rinforzo simultaneo di 30.000 uomini e la generalizzazione sapiente delle migliori pratiche di controinsurrezione. Qualcosa che ha rimodellato, ma non risolto del tutto, i dilemmi del paesaggio politico locale, cooptando la guerriglia sunnita e guadagnando un rapporto di forze favorevole per sconfiggere i gruppi jihadisti e l’Esercito del Madhi (vedi PDF 6, p. 44). Se non altro il surge ha permesso un ripiegamento più agevole nel 2010, tre anni dopo quanto inizialmente preventivato, pur lasciando alle spalle un paese dilaniato da molte contraddizioni, riesplose con il Califfato e il malcontento sunnita.
Machiavelli l’avrebbe compreso. Se i piani non servono, «la pianificazione è indispensabile». Nel suo pensiero preconizzava un esercito scaltro, avvezzo a «spregiare il vivere delicato»[xciv], capace di plasmarsi e modellarsi a seconda del nemico, nella dialettica delle volontà poi sussunta in Clausewitz (vedi PDF 7, p. 11). In Machiavelli spettava ai capitani prevenire sorprese e agguati, agendo con prudenza e servendosi di accurate ricognizioni. Squadre a cavallo avevano in carico l’esplorazione del terreno. Ovunque, la cavalleria stava conoscendo profonde trasformazioni. Unità leggere per l’avanscoperta e l’esplorazione sfruttavano la mobilità, la silenziosità e la velocità del mezzo per infiltrarsi repentinamente in territorio nemico.
Basti pensare ai Gineti arabi, punta di diamante delle truppe spagnole, o agli Stradioti albanesi, elite di quelle veneziane. In epoca contemporanea, i portoghesi impiegarono sistematicamente i cavalli per scovare e attaccare di soppiatto i guerriglieri angolani (1963-75). Le loro pattuglie erano formate in genere da 5 uomini[xcv]. Ma torniamo al ’500 e alla milizia fiorentina, impiegata dai Nove due sole volte, una prima, nell’assedio vittorioso contro Pisa (1509) e, una seconda, nella difesa fallimentare di Prato, espugnata dalle truppe spagnole e pontificie nel 1512. Né nel primo, né nel secondo caso, fu ingaggiato il nemico in campo aperto.
A Prato, le unità furono acquartierate nel perimetro urbano, con l’imperativo di tenere la città e bloccare la via di arroccamento a Firenze. Ma le truppe ispano-pontificie ebbero gioco facile. Più aduse all’arte della guerra, scardinarono le difese fin dal primo attacco, seminando il panico. Poco addestrate alle armi e alla disciplina, le bandiere non reagirono.
Degli oltre 4.000 morti, gran parte era loro. A parole, la centralità di comando era ritenuta imprescindibile per la rapidità decisionale della Milizia. Nei fatti il vertice politico-strategico era tripartito. I Nove avevano autorità in tempo di pace, i Dieci in guerra, mentre alla Signoria spettavano le incombenze amministrative, a partire dalla remunerazione. Mancava una catena di comando univoca. Gli ufficiali slittavano annualmente da un’unità all’altra, per impedire legami troppo solidi e possibili rivolte antigovernative.
Ma lo spirito di corpo e l’efficienza generale ne risentivano. Sebbene la vittoria del 1509 fosse stata una grande soddisfazione, era dipesa in molto dal contributo esterno. I miliziani non superavano le 2.000 unità, su svariate migliaia di mercenari[xcvi]. Come se non bastasse, Machiavelli aveva derogato ai principi di nazionalità e cittadinanza, affidando il comando dell’esercito a uno spagnolo, don Micheletto. Più tardi, se ne sarebbe pentito: «e’ capitani mercenari o e’ sono uomini eccellenti, o no; s’e’ sono, non te ne puoi fidare, perché sempre aspireranno alla grandezza propria […]»[xcvii]. Assoldare condottieri significava instaurare il più delle volte un rapporto malsano fra le armi e la politica. Il dux militare e lo Stato diffidavano spesso l’uno dell’altro.
Faticavano ad accordarsi sul compenso, sulla disciplina, sulla strategia e sull’organizzazione. Le decisioni cruciali erano spesso il risultato di una mediazione fra interessi contrastanti. Poco giorni dopo la conquista di Prato (settembre 1512), gli spagnoli al seguito del cardinale Giovanni de’ Medici misero fine alla repubblica del Soderini e alla carriera politica di Machiavelli. Paradossalmente, il Gonfaloniere si era negato un esercito permanente per evitare che truppe stabili ed esperte potessero cospirare a favore dei Medici. La tragedia finale rafforzò in Machiavelli l’aspirazione all’unità e la profonda amarezza per lo status quo. Qualsiasi vittoria ottenuta con «le armi aliene» gli sembrava fallace; meglio «perdere con e’ suoi che vincere con li altri»[xcviii].
Potremmo leggervi una critica ante litteram alla guerra per proxy, tanto in voga ai giorni nostri. Una metodica che presenta il vantaggio di abbinare alla massa «locale» le tecnologie avanzate di «proiezione», ma che presenta una miriade di rischi, a partire dall’incognita immanente di agende politiche differenti, passando per le norme etico-giuridiche, spesso non condivise. Per Machiavelli, principi e repubbliche sprovviste di soldati-cittadini avrebbero dovuto «vergognarsi», per non esser riuscite a fare dei loro uomini dei «militari»[xcix], avanguardia nazionale pronta alla morte piuttosto che a cedere[c]. Nessun re avrebbe mai potuto dirsi sicuro senza «uomini che, quando egli è tempo di fare guerra, volentieri per suo amore vadano a quella, e, quando viene poi la pace, più volentieri se ne ritornino a casa»[ci]. Urgeva «prepararsi a queste arme, per potersi con la virtù italica defendere da li esterni»[cii], come fecero Roma e Sparta.
«Stette Roma libera quattrocento anni, ed era armata; Sparta, ottocento; molte altre città sono state disarmate, e sono state libere meno di quaranta»[ciii]. Ricordando Castruccio Castracani, Machiavelli tracciò un ritratto ideale di principe-guerriero, al tempo stesso statista e condottiero. Sanguinario, versato nell’arte dell’inganno e della corruzione, Castracani era un grande conoscitore degli aspetti tattici, curati quasi maniacalmente da Machiavelli nell’Arte della Guerra.
Rigoroso nella disciplina, Castracani soleva «montare il primo a cavallo e l’ultimo scenderne», come si conveniva al miglior comandante. Machiavelli lo stimava, perché emblema dell’homo faber, capace di conquistarsi un principato, piuttosto che ereditarlo[civ]. Castracani era riuscito a farsi nominare capitano e difensore di Lucca (1317), città le cui fortune dipendevano dall’ubicazione strategica, lungo l’arteria principale dei pellegrinaggi fra l’oltralpe francese e la Roma dei papi. Era la famosa via Francigena, che passava per Siena, varcava l’Arno nei pressi di San Miniato e aggirava Firenze. Raggiunta Lucca, si ricongiungeva a nord con l’Aurelia, valicava il passo della Cisa e si arrampicava per i passi alpini.
Conclusioni
Sebbene carente in più parti, la dottrina machiavelliana aveva il merito di ricondurre la guerra ai suoi scopi naturali, esaltando l’importanza dei fattori spirituali nella lotta. Spagna e Francia testimoniavano quanto importante fosse la vastità dei possedimenti per l’ampiezza del bacino di reclutamento. Machiavelli andava oltre, quasi anticipando i canoni patriottici e nazionali che avrebbero informato gli eserciti dalla Rivoluzione francese in poi.
Sia in guerra che in pace, era consigliato al principe un unico obiettivo, affinare l’arte bellica, per difendere lo Stato ad ogni costo[cv]. Machiavelli preconizzava qui i futuri principi dell’arte bellica enunciati da Clausewitz, che riconducevano al potere politico le scelte effettuate nell’applicazione della forza: «lo scopo politico, motivo primo della guerra, darà dunque la misura, tanto dell’obbiettivo che l’azione bellica deve raggiungere, quanto degli sforzi che a ciò sono necessari»[cvi]. Si tratta di un ‘assioma’ spesso trascurato negli ultimi anni, in cui i dirigenti politici hanno mostrato di interessarsi di strategia, politica di difesa e capacità militari solo al momento dell’approvazione dei bilanci, sottodimensionando sistematicamente i dispositivi proiettati oltremare, e sottovalutando la durata degli impegni, con conseguenze dannose sul formato delle forze e sull’esito delle operazioni.
Dal Vietnam all’Afghanistan, passando per l’Iraq degli ultimi anni, i conflitti contemporanei ricordano quanto sia insufficiente la sola performance militare a garantire un’efficacia strategica e quanto sia problematico ricostruire da zero forze armate nazionali efficienti. É la storia recente della «diplomazia armata» americana a ricordarci quanti errori strategici sono stati commessi dalla Casa Bianca. Quando Barack Obama presentò il suo piano in quattro punti per debellare l’ISIS, parlò di una «guerra illimitata» ma non fece nulla per sostenerla e raggiungere il fine prestabilito, disdegnando invece l’invio di truppe americane a terra.
Machiavelli e Clausewitz l’avrebbero messo in guardia: «quanto più piccola è la forza disponibile, tanto più ristretti debbono essere gli scopi: inoltre, quanto minore è la forza, tanto più breve dev’essere la durata dell’azione»[cvii]. Obama si è rivelato un ‘principe’ incapace di fornire mezzi adeguati a un obiettivo di natura non limitata, facendo a pugni con gli insegnamenti dei Grandi. Ha anzi steso un tappeto rosso a quell’impeccabile stratega contemporaneo che è Vladimir Putin, abilissimo nel polarizzare lo scenario e dominare il nuovo grande gioco mediorientale, partendo da una disponibilità di mezzi infinitamente minore.
La Russia ha avuto fin dall’inizio una posizione chiara e coerente, alimentata da un obiettivo positivo, la vittoria del regime siriano, per quanto impresentabile, unico modo per preservare i suoi interessi, fra cui la base in espansione di Tartus, la neonata Hmeimin, e la ricerca di alleati sicuri contro il terrorismo islamico sunnita, vero male di questi tempi. Combattendo sul campo e riequipaggiando il Syrian Arab Army, Mosca ha rafforzato la sua credibilità internazionale, dimostrando fra l’altro di non abbandonare un alleato storico in difficoltà. Come se non bastasse ha riempito un ‘vuoto strutturale’, per dirla con i teorici delle reti. Avendo gli occidentali interrotto i rapporti diplomatici con Assad, qualsiasi negoziato di pace con la Siria lealista sta passando dalle mani russe, imprescindibili nella soluzione di un conflitto ormai quasi risolto in favore di Damasco.
Riecheggiano nell’agire politico di Putin gli insegnamenti del Grande Fiorentino, che già ammoniva: «dove si delibera al tutto della salute della patria, non vi debbe cadere alcuna considerazione né di giusto né di ingiusto, né di pietoso, né di crudele, né di laudabile né d’ignominioso, anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che gli salvi la vita, e mantengale la libertà»[cviii]. Per Machiavelli, chiunque avesse disdegnato «questi modi crudelissimi, o nemici d’ogni vivere non solamente umano, ma cristiano»[cix], avrebbe dovuto rinunciare all’idea di poter esser un giorno principe. D
isse una volta il pater patriae Camillo Benso di Cavour: «se facessimo per noi stessi ciò che stiamo facendo per l’Italia saremmo veri e propri malfattori»[cx]. Il genio del Conte per l’intrigo raggiungeva dimensioni eroiche, a detta di Talleyrand, ministro degli esteri francese. Machiavelli avrebbe senz’altro approvato. Ma sia chiaro una volta per tutte. Egli non era avulso ai principi di libertà e giustizia, anzi, «fingendo di dar insegnamenti ai re, ne ha dati di grandi ai popoli»[cxi]. Riteneva sbagliato affidare la propria sicurezza a un mon-arca perché questi, temendo insidie quotidiane, avrebbe tramato contro i sottoposti piuttosto che curarsene. Come se non bastasse disse esser lecito e lodevole estromettere un despota ed esaltò la figura di Junius Brutus, autore con Cassio della congiura contro Cesare (44 a.C.).
Esagerava tuttavia a indicare nel governo cesareo una tirannide stricto sensu. Cesare aveva assunto il potere con il pieno consenso popolare, non ne violò le guarentigie, fu magnanimo con gli avversari e sensibile verso la res publica. Dopo il colpo di stato, Roma precipitò nel clima di torbidi e di lotte intestine da cui proprio il Generale l’aveva liberata, consapevole della faziosità dell’aristocrazia senatoria. Quando Dante mise mano all’Inferno, non esitò a sbattervi i congiurati, rei come tutti gli impostori.
Nonostante le incongruenze storiche, il principio libertario del Machiavelli conservò integra la sua carica dirompente. Per Spinoza, l’opera omnia del Fiorentino era un’apologia delle libertà[cxii]. Per Rousseau, il Principe era il «libro dei repubblicani»[cxiii], perché indicava in quella forma statuale la miglior garanzia delle libertà individuali, della proprietà privata e della grandezza collettiva[cxiv]. Machiavelli biasimava le tirannidi e le crudeltà gratuite[cxv].
Proponeva un sistema politico capace di incanalare le energie conflittuali in meccanismi istituzionali ed esaltava il modus operandi della Repubblica romana, abilissima nel dirimere col dialogo politico le controversie patrizio-plebee[cxvi]. Fino all’epoca dei Gracchi (133-121 a.C.), istituzioni e ordini erano stati in grado di contenere le tensioni sociali, facendone strumento di crescita politica. Grazie a una costituzione mista, principe, ottimati e popolo avevano diritto di rappresentanza. Machiavelli mai condannò il tumulto delle pubbliche piazze e il valore dell’agorà, perché riconosceva nel conflitto politico un fattore dinamico e costituente. Riteneva inevitabili gli abusi di potere di un sovrano assoluto e raccomandava di preferire l’imperfezione e l’instabilità dei regimi che vivono di lotte aperte all’ordine ingannevole delle tirannidi monocratiche.
L’idea sottesa era quanto mai originale e fondata. La dialettica costruttiva di classe e tante guerre civili hanno prodotto nella storia buoni risultati, dalla nascita di istituzioni comuni all’affermazione del sentimento condiviso di patria. Basti pensare all’Inghilterra di Cromwell e della gloriosa rivoluzione; alla Francia rivoluzionaria e napoleonica; agli Stati Uniti del periodo secessionista; alla Spagna pre e post franchista e in buona parte all’Italia del dopoguerra. Col «vivere libero», i popoli conseguono dominio e ricchezza. Ma non vi è libertà senza sicurezza, così come non vi è giustizia, né equità dove il particolare primeggi sul bene comune. Nel ricordare i fasti passati, Machiavelli vagheggiava un futuro altrettanto prospero.
Anelava alla ‘Patria’, ma non era il tipo da cedere alla retorica e non risparmiò critiche ai suoi concittadini, incapaci di sublimare il coraggio individuale nel sacrificio collettivo. Fu un Grande politico, capace di indicare nel bene comune il fondamento della ragion di Stato. Pur costando sacrifici e talvolta sangue, lo Stato sottrae l’uomo al suo meschino egoismo e lo riporta alla dignità dell’ordine e della vita civile[cxvii]. E uno Stato sarà tanto più grande, quanto più riuscirà ad anteporre il tutto all’uno. O, se preferite, quanto più si avvicinerà alla Res-publica di Machiavelli[cxviii]. Qualcosa che molti nostri governanti farebbero bene a non dimenticare.
Note:
[i] Ralph Flenley, Modern German History, ediz. italiana: Storia della Germania, Milano, Garzanti, 1966, p. 9.
[ii] Niccolò Machiavelli Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio, libro II, Cap. XI, Milano, Sonzogno, [s.d.], pp. 158-159.
[iii] Paolo Malanima, L’economia italiana, Dalla crescita medievale alla crescita contemporanea, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 19.
[iv] Edward Mead Earle, Makers of Modern Strategy. Military Thought from Machiavelli to Hitler, Princeton, Princeton University Press, 1973, p. 6.
[v] Sergio Romano, I confini della storia, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 99-101.
[vi] Idem, p. 179.
[vii] Indro Montanelli, Roberto Gervaso, L’Italia dei secoli d’oro, Il Medio Evo dal 1250 al 1492, Milano, RCS, 2003, p. 200.
[viii] Vescovo di Volterra, ambasciatore della Signoria e fratello del gonfaloniere Pier Soderini.
[ix] Ramiro d’Orco, poco raccomandabile già dal nome.
[x] Si trattava di Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo e degli Orsini.
[xi] Raymond Aron, Machiavelli e Marx, saggio introduttivo all’edizione BUR del Principe (1990), pp. 10-11.
[xii] Machiavelli, Il Principe, Roma, Newton & Compton, 2005, cap. 7, p. 44.
[xiii] H.G. Koenigsberger, G.L. Mosse, G.Q. Bowler, Europe in the Sixteenth Century, ediz. italiana: L’Europa del Cinquecento, Milano, RCS, 2004, p. 469.
[xiv] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 26, p. 97.
[xv] Machiavelli, Discorsi, cit., libro I, cap. 58, p. 130.
[xvi] Umberto Cerroni, Il pensiero politico italiano, Roma, Newton & Compton, 1995, p. 35.
[xvii] Carlo VIII ne rivendicava il possesso in qualità di erede degli Angioini.
[xviii] Peter Burke, The European Renaissance. Centres and Peripheries, ediz. italiana: Il Rinascimento, Milano, Rizzoli, 2004, p. 98.
[xix] Aron, op. cit., p. 23.
[xx] Machiavelli, Discorsi, cit., libro I, cap. 12, p. 63.
[xxi] Montanelli, Gervaso, L’Italia della Controriforma, dal 1492 al 1600, Milano, RCS, 2003, pp. 547-548, 550-551.
[xxii] Gabriele Pedullà, Machiavelli in tumulto. Conquista, cittadinanza e conflitto nei «Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio». Roma, Bulzoni, 2011, pp. 341-418.
[xxiii] Francesco Petrarca, Il Canzoniere, Italia mia, benché ‘l parlar sia indarno, sonetto 128, versetti 23-24, versione on line.
[xxiv] H.G. Koenigsberger, Parlamenti e istituzioni rappresentative negli antichi Stati italiani, in AA.VV., Storia d’Italia, Dal feudalesimo al capitalismo, Torino, Einaudi, 1978, p. 583.
[xxv] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, libro IV, Sansoni, Firenze, 1971, PDF 9, p. 115.
[xxvi] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 15, p. 67.
[xxvii] Montanelli, Gervaso, L’Italia della Controriforma, cit., p. 554.
[xxviii] Ekkehart Krippendorff, Kritk der Außenpolitik, ediz. italiana: Critica della politica estera, Roma, Fazi, 2004, p. 14.
[xxix] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 18, p. 72.
[xxx] Idem, p. 73.
[xxxi] Nicola Abbagnano, Storia della filosofia, Torino, UTET, 1972, vol. II, p. 41.
[xxxii] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 18, p. 73.
[xxxiii] Idem, cap. 20, p. 85.
[xxxiv] Machiavelli, Discorsi, cit., libro I, cap. 58, p. 130.
[xxxv] Idem, cap. 5, p. 47.
[xxxvi] Idem, cap. 58, p. 131.
[xxxvii] Idem, cap. 18, p. 74.
[xxxviii] Idem, cap. 47, p. 114.
[xxxix] Idem, cap. 45, p. 109.
[xl] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 12, p. 58.
[xli] Ettore Bastico, Niccolò Machiavelli e il suo pensiero politico militare, Conferenza tenuta alla Scuola di Guerra il 23 febbraio 1924, Tipografia Enrico Schioppo, Torino, 1924, p. 43
[xlii] John Keegan, A History of Warfare, ediz. italiana: La grande storia della guerra, Dalla preistoria ai giorni nostri, Milano, Mondadori, 1996, pp. 266- 270.
[xliii] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 13, p. 64; Storie fiorentine, Firenze, Paravia, 1886, libro I, cap. 1, pp. 50-51. L’esercito, da romano e italico, era divenuto progressivamente provinciale e barbarico, per la continua immissione d’elementi germanici.
[xliv] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 12, p. 59. L’opinione era condivisa anche da Francesco Guicciardini.
[xlv] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro I, PDF 9, p. 14.
[xlvi] È l’epiteto del provenzale Montreal d’Alborno. Già appartenuto all’ordine dei Templari, fra’ Moriale fu ucciso per ordine di Cola di Rienzo.
[xlvii] Machiavelli, Storie fiorentine, cit., libro IV, cap. 6, p. 244. La battaglia di Zagonara (1424) vide contrapposti i mercenari ‘fiorentini’ e l’esercito di Filippo Maria Visconti, guidato al successo dal famoso Carmagnola. I fiorentini furono circondati e messi in rotta. Il comandante supremo, Pandolfo Malatesta, riuscì a fuggire, mentre il fratello Carlo cadde prigioniero; 3.200 cavalieri furono disarmati ed è verosimile che fra la truppa vi fossero molti caduti, tra cui il capitano Lodovico degli Obizi e un altro morto per annegamento.
[xlviii] Machiavelli, Storie fiorentine, cit., libro V, cap. 33, p. 347. Ad Anghiari (1440), l’esercito fiorentino si batté nuovamente contro i milanesi, in una lega promossa dal pontefice. Anche questa battaglia lasciò sul campo decine di morti e feriti, uomini e cavalli.
[xlix] Montanelli, Le stanze, Dialoghi con gli italiani, Milano, BUR, 2002, pp. 165-166.
[l] Marco Galandra, Le nuove fanterie dell’età moderna: i lanzichenecchi, in «Rivista Storica», aprile 1995.
[li] Platone, La Repubblica, libro IX, versione on line.
[lii] Charles C. Bayley, War and Society in Renaissance Florence: The “De Militia” of Leonardo Bruni, Toronto, University of Toronto Press, 1961, pp. 178-182.
[liii] Isocrate, Sulla pace, versi 44-47.
[liv] Flavius Vegetius Renatus, De Re Militari, libro II, cap. II, testo in latino disponibile sul sito della Bibliotheca Augustana.
[lv] La Virtù del Machiavelli coincide con l’Areté dei sosfisti greci: è un abilità in senso naturale.
[lvi] Burke, op. cit., p. 266.
[lvii] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro VI, PDF 9, p. 144.
[lviii] Idem, libro I, p. 116.
[lix] Scipione Guarracino, Storia dell’Età Medievale, Milano, Mondadori, 1988, p. 107.
[lx] Piero Pieri, Formazione e sviluppo delle grandi monarchie europee, in AA.VV., Nuove questioni di storia medioevale, Milano, Marzorati, 1964, p. 422.
[lxi] Machiavelli cita a memoria un passo degli Annales di Tacito (Il Principe, cit., cap. 13, p. 64).
[lxii] Geoffrey Parker, The military revolution. Military innovation and the rise of the West, 1500-1800, ediz. italiana: La rivoluzione militare. Le innovazioni militari e il sorgere dell’Occidente, Bologna, il Mulino, 1999, p. 110.
[lxiii] Machiavelli, Discorsi, cit., libro II, cap. 10, p. 157.
[lxiv] Ibidem.
[lxv] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 13, p. 63.
[lxvi] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., proemio, PDF 9, p. 5.
[lxvii] William H. McRaven, Spec Ops: Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Practice, Presidio Press, New York-Toronto, 1996, p. 23.
[lxviii] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 12, p. 59 e cap. 6, pp. 42-43.
[lxix] Idem, cap. 26, p. 97.
[lxx] Federico Chabod, Scritti su Machiavelli, Torino, Einaudi, 1993, p. 332; Michael Mallett, Mercenaries and their masters; Warfare in Renaissance Italy, Londra, The Bodley Head Ltd, 1974, p. 196.
[lxxi] Franco Catalano, Il problema dell’equilibrio e la crisi della libertà italiana, in AA.VV., Nuove questioni di storia medioevale, cit., p. 358.
[lxxii] Machiavelli, Discorsi, cit., libro II, cap. 16, p. 168.
[lxxiii] Idem, cap. 18, pp. 174-175.
[lxxiv] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro II, PDF 9, p. 56.
[lxxv] Ibidem, PDF 9, p. 59, 61.
[lxxvi] Idem, libro II, PDF 9, p. 59.
[lxxvii] Idem, libro VII, PDF 9, p. 181.
[lxxviii] Machiavelli, Discorsi, cit., libro II, cap. 18, p. 174.
[lxxix] Idem, cap. 17, p. 173.
[lxxx] Earle, op. cit., p. 20.
[lxxxi] Machiavelli, Discorsi, cit., libro II, cap. 17, p. 172.
[lxxxii] Erano necessari 8 cavalli per trasportare un cannone da 1,8 tonnellate.
[lxxxiii] Machiavelli, Discorsi, cit., libro III, cap. 11, pp. 239-240.
[lxxxiv] Raffaele Puddu, La guerra mediterranea e la difesa di Malta, in «Cooperazione Mediterranea», no 1-2/2003, pp. 45-46.
[lxxxv] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro II, PDF 9, p. 49.
[lxxxvi] Machiavelli, Discorsi, cit., libro II, cap. 17, p. 172.
[lxxxvii] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro I, PDF 9, p. 22.
[lxxxviii] Machiavelli, Storie fiorentine, cit, libro VI, cap. 1, pp. 352-353.
[lxxxix] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro V, PDF 9, p. 130.
[xc] Machiavelli Discorsi, cit., libro III, cap. 40, p. 286.
[xci] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro IV, PDF 9, p. 102.
[xcii] Machiavelli Discorsi, cit., libro III, cap. 33, pp. 206-207.
[xciii] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro VII, PDF 9, p. 181.
[xciv] Ibidem, PDF 9, p. 182.
[xcv] Alessandro Politi, Le dottrine tedesche di controguerriglia, 1936-1944, Roma, Ufficio Storico SME, 1991, p. 28, nota 20.
[xcvi] Responsabile dei rifornimenti era Machiavelli.
[xcvii] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 12, p. 59.
[xcviii] Idem, cap. 13, p. 63.
[xcix] Machiavelli, Discorsi, cit., libro I, cap. 21, p. 78.
[c] Idem, cap. 43, p. 108.
[ci] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro I, PDF 9, p. 19.
[cii] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 26, p. 97. Vedi anche Storie fiorentine, cit., libro I, cap. 39, p. 102.
[ciii] Machiavelli, Dell’Arte della guerra, cit., libro I, PDF 9, pp. 27-28.
[civ] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 25, p. 92.
[cv] Idem, cap. 14, pp. 65-66.
[cvi] Clausewitz, Vom Kriege, ediz. Italiana, Della guerra, Milano, Mondadori, libro I, capitolo 1, 11, p. 28.
[cvii] Idem, libro V, capitolo 3, p. 333.
[cviii] Machiavelli Discorsi, cit., libro III, cap. 41, p. 287.
[cix] Idem, libro I, cap. 26, p. 83
[cx] Danis Mack Smith, Cavour, Milano, Bompiani, 1985, p. 197.
[cxi] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique, ediz. italiana: Il contratto sociale, Milano, Fabbri Editori, 1996, libro III, cap. 6, p. 123.
[cxii] Baruch Spinoza, Tractatus politicus, ediz. italiana: Trattato politico, Torino, Paravia, 1958, pp. 108-109.
[cxiii] Rousseau, op. cit., p. 123.
[cxiv] Pier Paolo Portinaro, Profilo del liberalismo, in Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, ediz. italiana: La libertà degli antichi, paragonata a quella dei moderni, Torino, Einaudi, 2001, p. 61
[cxv] Machiavelli, Il Principe, cit., cap. 8, pp. 51-52.
[cxvi] Machiavelli Discorsi, cit., libro I, cap. 3-6, pp. 43-51.
[cxvii] Mario D’Addio, Storia delle dottrine politiche, Genova, ECIG, 1992, vol. I, pp. 281-282.
[cxviii] Machiavelli Discorsi, cit., libro II, cap. 2, p. 141.

Francesco PalmasVedi tutti gli articoli
Nato a Cagliari, dove ha seguito gli studi classici e universitari, si è trasferito a Roma per frequentare come civile il 6° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze. Analista militare indipendente, scrive attualmente per Panorama Difesa, Informazioni della Difesa e il quotidiano Avvenire. Ha collaborato con Rivista Militare, Rivista Marittima, Rivista Aeronautica, Rivista della Guardia di Finanza, Storia Militare, Storia&Battaglie, Tecnologia&Difesa, Raid, Affari Esteri e Rivista di Studi Politici Internazionali. Ha pubblicato un saggio sugli avvenimenti della politica estera francese fra il settembre del 1944 e il maggio del 1945 e curato un volume sul Poligono di Nettuno, edito dal Segretariato della Difesa.










